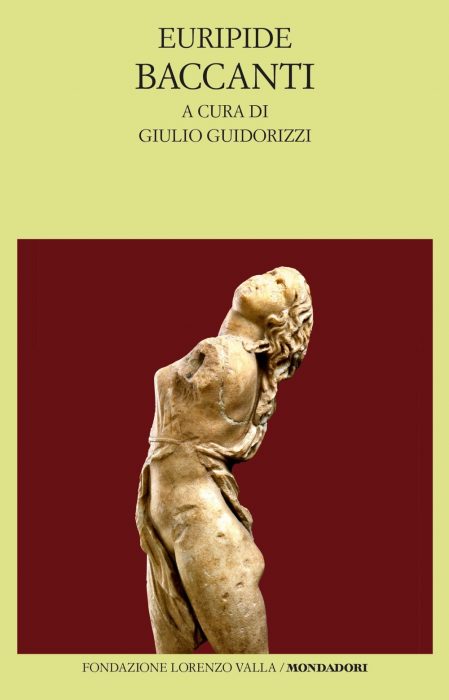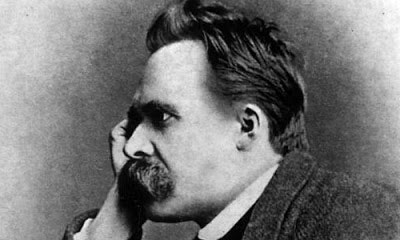
«Quando scruterai a lungo in un abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te», scriveva Nietzsche. Nelle Baccanti questo abisso è Dioniso e leggere le Baccanti significa assistere al tuffo nell’abisso. E’ inutile cercare di opporsi, si viene trascinati dentro. E sul fondo che cosa c’è? Il sangue e la morte, una madre folle che fa a pezzi il figlio, oppure la pace e l’armonia, come afferma il Coro? Il nucleo attorno a cui è costruita a tragedia è la perdita del Sé, per affondare in una dimensione che scavalca la ragione e ne svela la fragilità. Quando, contro la loro volontà, il re Penteo e sua madre Agave passano quella soglia, ciò che vedono non è più la realtà, ma un mondo annebbiato e popolato da fantasmi. Le baccanti del Coro, invece, danzano e si abbandonano gioiosamente alla forza che scorre nelle loro vene; un dio entra nel loro corpo, ed esse si sentono tutt’uno con lui: che ci può essere di più esaltante?
In questa tragedia, l’ultima prodotta dal grande teatro del V secolo a.C., Euripide ripropone in modo emozionante e terribile quello che era stato uno tra i temi fondamentali del suo teatro, cioè il conflitto tra ragione e irrazionale, come in Ippolito e Medea: del resto, dicevano gli antichi critici, Euripide fu grande nel rappresentare l’amore e la follia. Ma nelle Baccanti si tratta di una follia speciale: quella collettiva del rito di trance. Così, alla fine della sua grande stagione la tragedia torna a volgersi verso il suo dio patrono, anche se questo “ritorno a Dioniso” avviene attraverso l’occhio polemico, e si può ben dire laico, di un uomo che aveva vissuto da protagonista la grande rivoluzione intellettuale dell’Atene del V secolo, un’epoca in cui erano molti quelli che proclamavano di voler sottoporre ogni cosa al tribunale della ragione. Le Baccanti invece mostrano grandiosamente i due poli opposti dell’irrazionale: quello cupo e devastante della pazzia e quello estatico che libera dai lacci e dilata la personalità.
Solo lasciando libera strada alla follia, proclama il Coro, si può esplorare l’estremo confine della mente umana: «non è saggezza il sapere», osano dire le baccanti. I rituali estatici di Dioniso pretendevano di offrire, attraverso la trance, una forma diversa e superiore di conoscenza, contrapposta a quella ricercata dalla ragione. In questo senso, Dioniso può apparire come la forza che governa la vita in fermento e si lascia intuire attraverso il caos dei baccanali, ovvero, per usare le parole di Karl Kerényi «una follia connaturata al mondo stesso, non quell’alterazione passeggera o permanente che può colpire un uomo come malattia, non un’affezione, dunque, né una degenerazione della vita, ma la compagna della sua perfetta salute».
Le Baccanti non si possono interpretare con categorie puramente teatrali o filologiche; per comprendere il testo euripideo bisogna comprendere in primo luogo il valore culturale che assumeva la follia in Grecia, e in particolare le forme della follia sacra posta sotto il patrocinio di Dioniso. Nella prospettiva greca, infatti, la follia non era concepita solo come solo l’opaco cedimento dell’anima ai suoi lati peggiori e neppure come il sanguinario delirio di un tiranno. Nella follia si scorgeva anche qualcosa di gioioso ed esaltante, un potenziamento dell’anima e non il suo crollo.

Ad affermarlo è il più illustre dei testimoni, Platone: gli antichi ritenevano la follia tanto superiore alla sapienza in quanto l’una proviene dagli dei, l’altra dagli uomini. Poco oltre, egli definisce quattro forme di follia prodotta da «un divino straniamento» rispetto alle normali regole di condotta: quella profetica, regolata da Apollo che invade la mente della Pizia e la rende capace di predire il futuro; quella poetica grazie alla quale gli uomini ottengono dalla Muse il dono dell’ispirazione, e solo allora può esservi arte; quella erotica generata da Afrodite che plasma e trasforma l’anima di chi ama; quella iniziatica che appartiene al dominio di Dioniso.
Alcune forme di alterazione del comportamento erano dunque interpretate, nella cultura greca, non in termini di aberrazione mentale ma piuttosto come accrescimento della personalità: in esse la mentalità tradizionale vedeva l’intervento di una forza soprannaturale che penetrando nel corpo di un uomo e alterandogli la mente lo rendeva capace di manifestazioni straordinarie.
La follia “iniziatica” – quella delle Baccanti – si può definire come una forma di esaltazione collettiva, ottenuta attraverso un rituale estatico e posta sotto il patrocinio di un dio: appunto perché socialmente accettata e collettivamente riconosciuta, questo tipo di alienazione si trasforma in una vera e propria istituzione culturale che ha come fine il recupero della stabilità psichica ed emotiva dell’individuo, oltre che il controllo sociale della pazzia.
I riti di Dioniso, descritti da Euripide nelle Baccanti con l’accuratezza di un etnologo, sono ambigui e terribili, e oscillano tra i poli della rinascita e dell’annientamento. Il fedele sperimenta un’esperienza di dissolvimento dell’identità: precipitando in uno stato che noi definiamo trance e i Greci ἔκστασις (“uscita da sé”) oppure ἐνϑουσιασμός (“essere invaso dal dio”), il seguace di Dioniso diventa un un “uomo dentro cui dimora un dio”. Alla sua personalità abituale si sovrappone un’altra e più terribile personalità, che s’impossessa del suo corpo e della sua psiche per abbandonarlo poi, immemore, alla fine del rito. «Vengono detti posseduti – scriveva un antico commentatore – coloro a cui è tolto l’intelletto a causa di una visione e che cadono sotto il potere di un dio che invia loro questa visione e fa fare loro ciò che vuole». La danza, la musica, la trance sono elementi primordiali dell’esperienza del sacro, che le religioni storiche hanno poi quasi completamente accantonato e che invece nella Grecia classica erano pienamente vitali.
La spiegazione che la mentalità religiosa dava alla possessione era che una forza divina entrava nel corpo di un essere umano; per un osservatore neutro, invece, quello che capita ai posseduti è presente in qualche piega segreta dell’anima umana. «Per quanto tu cammini per ogni via, diceva Eraclito, i confini dell’anima non li troverai», e i rituali estatici portano molto lontano su questo misterioso cammino. Le Baccanti lo dimostrano. Quella che Dioniso propone ai Tebani è un’esperienza per molti aspetti regressiva. La società organizza attraverso i secoli le regole della sua civiltà, la città, le leggi, le sue categorie di pensiero, ma vi è una parte dell’uomo che rimane fuori; in questo mondo “altro”, dischiuso dall’esperienza dell’estasi, i limiti e le barriere create dalla cultura si dissolvono e il controllo della mente si annienta. Si annientano anche le forme sociali. La città, intesa come il luogo in cui regnano le leggi, si svuota; una metà, le donne – cioè quelle escluse dai meccanismi di governo – lasciano la casa e il telaio e si rifugiano sulla montagna. Lì sono libere da ogni costrizione; nessuno le obbliga alle regole della famiglia, nessuno le opprime. Regrediscono allo stato di natura: si vestono di pelli d’animale, cacciano, danzano, dimenticano la famiglia e persino i figli neonati. Allattano cuccioli di lupi e cerbiatti, in una maternità indifferenziata, non regolata dalle forme della società, ma dilatata nella natura. Sono libere. Anche se possedute: questo è il paradosso.
Così infatti Euripide le descrive subito all’inizio delle Baccanti: le folli seguaci del dio irrompono sulla scena danzando vorticosamente, come in preda a un’energia irrefrenabile: hanno percorso correndo un lungo tratto di terra, hanno ballato senza mai stancarsi al suono degli strumenti sacri, il flauto e il tamburello. Celebrano le gioie arcane della loro condizione ottenuta scavalcando i confini ristretti dell’esistenza: beato – dicono – «chi confonde l’anima nel gruppo».
«Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia», scriveva Giuseppe Ungaretti. Forse, è un sentimento simile ciò che spingeva i seguaci di Dioniso a trovare rifugio nel culto estatico. Stringere i legami tra sé e gli altri, scavalcare i limiti della condizione umana, scordare il peso degli anni e i dolori della vita, eliminare le differenze sociali e la propria infelicità personale, dimenticare se stessi per tornare a confondersi con l’indifferenziato Uno da cui ogni cosa proviene: ecco il richiamo che i culti estatici propongono a chi vi si abbandona. «È dolce – dice il decrepito Cadmo travestito da menade all’inizio delle Baccanti – dimenticare di essere vecchi», ed è proprio l’oblio di questo ed altri tormenti ciò che attira chi vive un rituale estatico.
Grazie all’esperienza della trance il fedele assaporava il gusto di una misteriosa felicità che quando si è padroni della sua ragione non si conosce: “felice come la puledra che pascola accanto alla madre è la baccante», dice il Coro, e chi si dedica all’estasi del culto di Dioniso proclama se stesso «beato» (μάκαρ): in pace con il mondo, sente profumi soavi, ha visioni esaltanti, regredisce sino a una condizione di beatitudine originaria. Allora il grande abbraccio della follia si apre, in apparenza pietoso. Fuggire sui monti tra grida e danze, cadere in trance e dimenticare se stessi – ciò che si esprime col verbo βακχεύειν vale a dire identificarsi con la divinità di possessione – può non essere la soluzione a ogni tormento della vita, ma per gli adepti di Dioniso funziona.
La misteriosa energia psicotropa sprigionata dalla musica e dalla danza, grazie alle quali un individuo annienta la sua personalità e in questo annientamento scopre una misteriosa via di redenzione, è nelle culture più diverse il mezzo a cui l’umanità ricorre per evadere dai ceppi del corpo. La follia sacra, vissuta nell’isolamento del mistico che smarrisce l’anima, oppure cercata nel caos del rito collettivo, consente a chi la vive l’oblio del gravoso limite contro il quale si scontra la coscienza. Il principio d’individuazione, su cui l’uomo fonda la sua identità, è la diga che gli permette di essere e di pensarsi, ma la tensione a mescolarsi nuovamente con le grandi forze dell’universo agisce profondamente sulla sua anima. In quest’ottica, la trance appare come il mezzo attraverso il quale un individuo perviene a reintegrarsi con l’insieme più vasto che lo contiene, e che di volta in volta può essere identificato con un dio, o il mondo degli spiriti o la natura oppure la stessa società umana o forse anche con una parte sconosciuta di se stessi, attraverso quella che si potrebbe considerare una forma di psicoterapia rituale.
Se si diviene seguaci di un culto di possessione, spesso ciò accade perché il neofita non ha altra scelta per uscire dalla crisi psicologica in cui si trova; è in quell’ambito che cerca di ricomporre le parti spezzate della sua anima; il processo di reintegrazione si innesca nel momento in cui una persona proietta il proprio conflitto interiore in una dimensione esterna al suo io, verso la divinità da cui è convinto di essere chiamato.
Chi si avvia a una danza estatica è consapevole che sta per divenire vittima di un contagio che passa dall’uno all’altro come un incendio; sa anche che si avvia a un’esperienza dalla quale uscirà profondamente trasformato. Non sempre la chiamata del dio è indolore o spontanea. «Io ho costretto (ἠνάγκασ’) le donne di Tebe a vestire i paramenti del mio culto, dopo averle trafitte col pungolo della follia, e a fuggire via da casa», dice Dioniso all’inizio del dramma. E’ un’idea antropologicamente corretta: in genere, chi partecipa a un rito di trance lo fa in seguito a una chiamata da parte della divinità che obbliga i suoi adepti a servirla. Entrare nel gruppo dei seguaci di una divinità estatica significa quindi, in generale, obbedire, non scegliere. Per questo le baccanti corrono sul monte, e lì, in uno spazio dove la città non fa più sentire la sua costrizione, corrono incontro al loro dio.

Le Baccanti come testo teatrale
Euripide compose le Baccanti tra il 408 e il 406 a.C., quando si trovava in Macedonia ospite del re Archelao. A quell’epoca il poeta si avvicinava agli ottanta anni: ultima manifestazione di grandezza di un uomo che fu capace di rinnovare sino alla fine della sua vita il proprio linguaggio artistico. La tragedia fu rappresentata postuma ad Atene insieme al perduto Alcmeone a Corinto e all’ Ifigenia in Aulide. Secondo l’argomento antico (che risale ad Aristofane di Bisanzio), la trilogia ottenne la vittoria ai concorsi dionisiaci del 403 a.C.
Rispetto ai drammi dell’ultimo periodo, come Ione, Elena od Oreste, in cui prevaleva il gusto per un intreccio complesso e per tematiche di evasione, una sorta di tragicommedia quindi, le Baccanti propongono una ritorno verso forme antiche di tragedia, sia nella materia che nella struttura drammatica. Il Coro non è un semplice interlocutore lirico, come avviene spesso in Euripide, ma partecipa all’azione, recuperando l’interazione coi personaggi secondo lo schema del “recitare insieme” proprio della fase più primitiva della tragedia.
Tuttavia, è un elemento originale il fatto che mentre in genere il Coro rappresenta la voce della polis, nelle Baccanti è composto dalle profetesse straniere di un culto sovversivo che contestano fortemente la città e i valori cittadini. Le scene della tragedia sono concatenate strettamente tra loro, così da dare luogo a una vicenda compatta che procede in un crescendo di tensione sono allo scioglimento finale, senza momenti morti e senza neppure il ricorso insistito in quei canti a solo (monodie) che è invece caratteristiche del teatro euripideo. A differenza di quanto spesso accade, Euripide non romanza né varia il mito, ma si attiene anche nei dettagli alla tradizione di precedenti drammi di contenuto dionisiaco, a partire dal Penteo di Tespi (il fondatore della tragedia attica) e ad Eschilo, autore di due trilogie dedicate a Dioniso: la Licurgia, che comprendeva Edoni, Bassaridi, Giovinetti e trattava della sfida lanciata a Dioniso dall’empio re Licurgo di Tracia e la sua rovina (un tema affine alle Baccanti), e un’altra trilogia di argomento tebano che comprendeva Semele, Xantriai, Penteo (oppure, in alternativa Baccanti).
Il conflitto tragico che sta alla base delle baccanti è stato cercato di volta in volta nell’antitesi tra misticismo e ragione, tra fede e spirito critico, tra legge divina e società umana; si è visto persino in quest’opera una sorta di conversione in extremis dell’ateo Euripide ai valori religiosa. Molti peraltro sono gli intrecci in quest’opera: hanno una parte importante il conflitto tra natura e cultura, tra leggi cittadine e spirito primitivo e naturalmente tra ragione e follia; si potrebbe aggiungere, tra mondo maschile padrone della città e ribellione femminile.
Sulla scena, inevitabilmente, sta la città; ma subito fuori di Tebe, sul monte Citerone, si è costituita una sorta di anticittà femminile; questa irrompe sulla scena grazie a due racconti di messaggeri, tra i più belli ed emozionanti di tutto il teatro greco. Lì, sul monte, si apre un mondo completamente diverso ed estraneo, totalmente “altro”: fatto di sangue, follia, danza, disordine.
L’arrivo di Dioniso a Tebe è devastante – e del resto nelle Baccanti compare una scena di terremoto – perché fa crollare un ordine consolidato per spalancarne uno nuovo, spaventoso e inevitabile. Tebe ha l’aspetto di una città assediata; il re Penteo appare via via sempre più isolato e inerme, mentre prende forza ovunque attorno a lui, e infine anche dentro di lui, l’assalto delle oscure energie che la follia dionisiaca ha diffuso ovunque come un contagio. Il Dioniso delle Baccanti è inafferrabile sin dal primo istante in cui compare sulla scena mascherato; mascherarsi del resto è nella natura più profonda di questo dio, perché Dioniso è colui che non si può comprendere, colui che fa percepire qualcosa di totalmente diverso e nuovo: si potrebbe dire, affigura l’alterità assoluta. Dioniso si maschera, le sue fedeli si mascherano, Penteo si maschera; persino Cadmo e Tiresia, i due furbi vecchi, si mascherano pur rimanendo estranei alla dimensione della possessione. Certo è una scena grottesca: ma il registro comico appare più volte nella trama di quella che è una delle tragedie più disperate; anche la scena della follia di Penteo, e del suo travestimento quasi fosse un manichino oscilla tra il comico e il terribile.
Tutti i personaggi, in qualche modo, si mascherano. Ma cosa c’è sotto la maschera? Forse, un’altra maschera. Quando, nel secondo episodio, Penteo contempla sospettoso per la prima volta il dio travestito, ai suoi occhi compare un giovane dalla pelle chiara, dai capelli lunghi, vestito all’orientale, con un sorriso ironico sulle labbra, e il re prova verso di lui, oltre che una ripulsa istintiva, la percezione di qualcosa di lontano e sovversivo, estraneo a tutti gli uomini e a tutti gli dei che conosce. Però lo Straniero che lui combatte – in quel momento Penteo non è in grado di capirlo e non lo capirà mai – non è altro, in realtà, una faccia segreta di se stesso: anche lui diventerà folle e danzerà.

E’ soprattutto la contiguità psicologica tra Dioniso e Penteo ciò che impedisce una netta contrapposizione tra le due figure: perché Penteo diventa sempre più simile a Dioniso. La follia che emerge in lui lascia intravvedere nell’anima di questo rigido difensore della moralità gli stessi tratti che lui rimprovera alla beccanti e al loro dio: come diceva Winningtom-Ingram, «il dio che lui combatte è in realtà la parte più profonda di se stesso: la sua vanità, la sua arroganza, la sua presunzione, la sua insicurezza, la sua nascosta sessualità». Chi è dunque Penteo? Il tirannello delle prime scene, il folle travestito da baccante che lascia emergere le sue pulsioni segrete e desidera spiare le donne mentre fanno l’amore, o la vittima sacrificale che nell’ultimo momento della sua vita si strappa la maschera da baccante e mostra il suo volto terrorizzato davanti alla morte? Tutte queste cose insieme, perché in fondo anche lui è travolto dalla dimensione dionisiaca, che è caos, movimento, mutamento.
Ovviamente Dioniso trionfa; però quando la tragedia finisce, è impossibile riconoscere in lui la divinità gioiosa di cui le menadi avevano cantato le lodi all’inizio. Quando Dioniso esce di scena ormai del tutto indifferente alle sciagure umane, partendo da Tebe dopo avere annientato la sua stessa famiglia e indotto una madre a fare a pezzi suo figlio, la felicità e l’oblio dei mali che egli proponeva paiono non essere altro che un atroce inganno. E’ vero che gli empi vanno puniti, ma non è priva di ragione la morale che Cadmo gli obietta: «non sta bene che gli dei rivaleggino con gli uomini nell’ira».

Questo non basta per dire che la tragedia sia costruita per smascherare la finzione divina, e non solo per l’abbastanza ovvia osservazione che un dio greco non è necessariamente una figura morale. Se infatti la tragedia fosse una sorta di parabola del tantum religio potuit suadere malorum e Dioniso fosse il simbolo della divinità crudele e ingiusta, allora Penteo dovrebbe essere in qualche modo nobilitato come l’antagonista, sventurato ma nobile, rispetto alla forza brutale che lo schiaccia.
Penteo però non ha nulla di questo, ed è inverosimile che così lo interpretasse il pubblico; egli assume piuttosto i tratti del tiranno tragico: arrogante, autoritario, con una tendenza all’emotività irrazionale (del resto sulla scena compare già tutto turbato), violento. Cadmo stesso, che pure lo ama, lo definisce «il terrore dellla città». Occorre un po’ di sforzo per vedere in lui una «figura schietta e simpatica», come sosteneva Pohlenz, un uomo guidato «dal solo interesse dello stato, di cui crede in pericolo la disciplina e l’ordine»; quest’uomo schietto e simpatico entra in scena minacciando sua madre, proclamando di voler imprigionare le baccanti e tagliare la testa al loro prete, e poi di voler salire sul monte Citerone a fare strage di donne.
E che dire di quell’aspetto puerile con cui il re crede di vendicarsi dell’insolenza di Tiresia ordinando che vengano scompigliate tutte le sue cose? Che Dioniso vinca è scontato, ma la caratterizzazione di Penteo non possiede nemmeno un’ombra dei tratti di grandezza che sulla scena attica accompagnano persino i malfattori e i sacrileghi.
A ben vedere, più che essere il difensore della ragione contro l’irrazionale, Penteo esprime la crisi della ragione, nella sua ostinazione, nella sua rigidezza, nel suo gretto conformismo: perché una mente che rifiuta di vedere il diverso e non lascia spazio al dubbio è una mente che fallisce il suo compito. Penteo si ostina a non vedere la forza del dio; chiude gli occhi davanti a ciò che sta diventando travolgente. E chiaro a tutti. S’illude di poter chiudere lo spazio aperto da Dioniso nella sua città sino ad allora ordinata e rassicurante; è preso dalla smania di chiudere in prigione chiunque rappresenta il disordine e l’irrazionale, in una parole “l’altro”. Tutto ciò tradisce la fragilità del suo spirito e anche l’oscura tensione verso le stesse forze contro cui reagisce tanto violentemente.
Come la vertigine non è la paura del vuoto, ma l’attrazione dell’abisso, così il fanatico conformismo di penteo – dal canto suo, tutt’altro che mentalmente lucido – segnala la tensione a rimuovere quello che egli non riesce a riconoscere di se stesso. Più ancora della clamorosa scena finale, c’è nelle Baccanti un momento terribile nella sua essenzialità: senza colpi di scena, senza mutamenti esteriori, vi è un preciso istante in cui il re incomincia a scivolare oltre i margini silenziosi della follia, verso l’annullamento della ragione:
DIONISO (lancia un grido) Aaaaah! (Penteo si blocca, qualcosa muta nel suo atteggiamento). Vuoi vedere le donne tutte insieme sul monte?
PENTEO Oh, se lo voglio. E lo pagherei a peso d’oro.
DIONISO Come mai sei stato preso da questo gran desiderio?
PENTEO Soffrirò, a vederle ubriache.
DIONISO E vuoi vedere ciò che ti farà patire?
Così, le contraddizioni che si agitavano dentro la mente di Penteo si rivelano da un momento all’altro, in termini di sofferenza psicologica e sdoppiamento della volontà, come se si spalancasse una porta.
Penteo è un uomo mediocre e conformista, aggrappato alle formule della morale tradizionale; ma il personaggio di Penteo cresce dal punto di vista drammatico quando cessa di essere il re. Allora, mentre vinto, umiliato, folle, si avvia verso il monte dove subirà il suo destino, sembra l’esempio della fragilità umana, che giustifica la morale Cadmo: «se c’è qualcuno che guarda agli dei con superbia, osservi questa morte e impari a credere in loro».
Non sembra che in questa tragedia sia possibile vedere un messaggio di etica religiosa; Euripide non è Eschilo e Penteo non è Prometeo. A differenza di altre storie di dolore proposte dal mito tragico (come quella di Edipo, Oreste o Antigone), c’è qualcosa di irrimediabilmente desolante nella fine di Penteo. La sua morte avviene sotto il segno dell’abbrutimento, in una scena in cui i codici espressivi oscillano tra il macabro e il grottesco. L’ultima immagine che la tragedia offre di Penteo è di totale cedimento: in cima a un albero, travestito, assediato da una torma di donne fanatiche, piange, supplica, urla sinché gli resta un soffio di respiro.
Certo questa è una fine atta a suscitare gli estremi di «pietà e terrore», che secondo Aristotele erano i fini ultimi della tragedia; tuttavia dietro quest’epilogo sta un grande vuoto, perché il sacrificio di Penteo non riscatta nessuno, non purifica nessuno, lascia del tutto irrisolti i dubbi e i problemi che esistevano all’inizio del dramma. Penteo è diventato una vittima sacrificale e lo sparagmòs è stato compiuto da sua madre; però il re non è stato né redento né santificato.
In questo senso il dramma non ha soluzioni; si sarebbe tentati di ripetere per le Baccanti ciò che un commentatore antico scrisse per l’Oreste: «contiene solo caratteri cattivi». Ma hanno un carattere davvero i personaggi delle Baccanti? Non nel senso che potremmo dire in generale per gli altri personaggi euripidei, vale a dire come stabile possesso di una personalità morale e intellettuale, in sostanza di un ethos. La personalità di questi personaggi si svuota, nel momento in cui il dio la scrolla; alcuni sono travestiti e fanno finta di essere quello che non sono (Cadmo e Tiresia), altri (Agave, Penteo) non sanno nemmeno chi sono.
Dioniso è il vertice a cui convergono tutti i fili del dramma. Sembra vicino e presente, ma in realtà si muove in una dimensione di insondabile lontananza. Di volta in volta, appare come il sereno signore dei simposi, il demone della follia, il fondatore di nuove forme di conoscenza, il dio che dissolve barriere e dona felicità, il nemico della famiglia e della città., il Punitore, il Redentore. Le Baccanti descrivono la fondazione di un nuovo culto, ma questo non è affatto presentato come un arricchimento della vita cittadina.
Dioniso e Penteo si affrontano ed è il loro faccia a faccia che occupa le scene centrali del dramma. Ma in questo scontro accade che a poco a poco le distanze anziché allargarsi si riducano. Sembra che Euripide presenti Dioniso e Penteo come figure speculari, anche se la dinamica dei personaggi procede su linee opposte: mentre Penteo si avvicina a Dioniso sino al punto da indossare i paramenti della baccante, Dioniso assume i tratti autoritari che appartenevano al re all’inizio del dramma, diventa tagliente e imperioso.
Entrambi si mascherano e cambiano identità, entrambi sono di volta in volta vittime e cacciatori. Dioniso però inseguito e preso nella rete conduce progressivamente il suo antagonista ad essere preda di una caccia. Entrambi sono in modi diversi vittime sacrificali; Dioniso in quanto dio sofferente, nato da un parto di morte, simbolicamente raffigurato dalle sue seguaci nello sparagmòs rituale che compiono sui monti; Penteo (il suo nome del resto significa «il Sofferente») rappresenta quella stessa vittima squartata dalle baccanti.
I due personaggi vivono una dimensione iniziatica: Dioniso entra a Tebe per la prima volta, diventa “cittadino” della sua patria e fonda il suo culto; Penteo entra nel gruppo iniziatico delle baccanti. Nell’intreccio delle Baccanti le tematiche simboliche ispirate a riti iniziatici occupano un ruolo importante. La lunghezza della chioma di Dioniso, il suo carattere androgino, il suo mutamento d’identità. Il travestimento di Penteo riflette del resto un rituale che era ben familiare al pubblico di Euripide: durante le Oscoforie due giovani travestiti da femmina guidavano la processione dal santuario di Dioniso in Atene a quello al Falero; ciò trova una puntuale corrispondenza nella tragedia, quando verso il Citerone muove una “processione” di due individui mascherati che si avviano verso la celebrazione di un vero sacrificio dionisiaco.
L’insistenza sulle forme di pazzia, l’attenzione con cui vengono descritte le manifestazioni che trasformano un essere umano in un mostro feroce, come accade ad Agave, oppure in un docile demente privo di volontà (come tocca a Penteo), l’indagine sui fenomeni dell’irrazionale, sono i temi più profondi della tragedia e insieme il motore che mette in azione le scene più belle del dramma.
La tematica della follia, come si è detto, non è certo ignota ad Euripide. L’Eracle presenta un’altra notevole descrizione di un eroe, vittima di un improvviso accecamento della ragione. Eracle impazzito stermina i propri figli e trascorre dal colmo della gloria a quello della miseria in pochi istanti, vittima di una patologia che investe in vari modi altri eroi euripidei: Oreste, Medea, Fedra. Del resto, i tragici furono profondamente attirati dalla dimensione della follia; nel V secolo a.C. le sofferenze di eroi deliranti erano un tema ricorrente, basta pensare all’Oreste di Coefore ed Eumenidi, alla Cassandra nell’Agamennone, a Io nel Prometeo, di Aiace nell’omonima tragedia sofoclea. Si potrebbe dire che il modello di eroe proposto dalla tragedia attica è in un certo senso spontaneamente orientato verso la follia, proprio perché l’eccesso appartiene alla sua stessa natura, nel momento in cui osa varcare i limiti imposti agli altri mortali. L’accecamento (ἄτη) che oscura la ragione di un individuo e lo conduce alla dismisura (ὕβρις) erano schemi di pensiero che la tragedia ereditava dal sistema d’idee tradizionale (basta leggere Erodoto e Pindaro) e che s’innestavano in modo inestricabile sul patrimonio mitico che formava la materia dell’azione drammatica.
I tragici tuttavia diedero alla dismisura insita nell’eroe del mito una dimensione patologica, estranea alla poesia epica, e ciò anche in rapporto alla cultura attica contemporanea. L’operazione compiuta dai tragici fu di tradurre il mito eroico nei termini dei conflitti e dei problemi della società ateniese e soprattutto dare un voce a ciò che si agita dentro l’anima di un uomo. È una vera e propria rivoluzione: l’azione drammatica consente di mettere a nudo l’anima dei personaggi le loro contraddizioni, in sostanza di dare una terza dimensione alle figure del mito.
Isonomìa (“parità davanti alle leggi”) e isegorìa (“parità di parola”), erano i pilastri su cui fonda la democrazia ateniese; tutti uguali davanti alla legge, tutti uguali in assemblea. Ma la tragedia greca dice anche : tutti uguali davanti alle passioni. La tragedia, portando sulla scena i movimenti profondi dell’anima, mostra il regno degli impulsi che si traducono in passioni e poi in delitti, un mondo dove avviene l’ineluttabile e la ragione non lo frena, un mondo (per dirla con Nietzsche) «così mutevole e vario da ripugnare a un animo riflessivo, e da potere invece suscitare un fuoco pericoloso in animi eccitabili e sensibili».E’ appunto con la tragedia che la passione s’interiorizza, diventa un inquilino dell’anima con il quale bisogna fare i conti sempre, perché non fugge via come una nuvola, ma sta dentro a covare e a scavare.
L’aspetto forse più “tragico” della tragedia è che i suoi personaggi – come in fondo la vita stessa – esprimono il disperato conflitto tra libertà e sovradeterminazione, e sempre la prima è sconfitta. Se da un lato infatti sembra che l’essere umano sia libero di scegliere e di agire, dall’altro questa libertà è limitata da forze esterne, con cui sempre ci si scontra. Ma la limitazione proviene anche da dentro: un essere umano può essere spinto alla rovina dalle energie inconsce che si agitano nel suo interno, e dalle passioni di cui non ha il controllo. Come Medea, che nel momento in cui si avvia a uccidere i suoi figli dice: «so quali delitti sto per compiere ma il mio animo è più forte della ragione».
Tra le domande che le Baccanti portano con sé, una continua a doversi porre: quali sono i limiti della ragione? Che cosa trasforma, in un momento, un essere umano in un animale che caccia e uccide a mani nude e non ha più consapevolezza di sé?
Il contributo principale della tragedia greca alla storia della cultura – oltre che naturalmente a quella della letteratura – fu senz’altro la scoperta del mondo interiore. L’eroe tragico, una creatura tormentata e insieme terribile, porta dentro di sé le proprie emozioni, che ribollono in un complicato orizzonte psicologico.
Un’epoca di straordinario sviluppo intellettuale, in cui i confini della ragione furono spinti molto più in là. Ma gli anni della guerra del Peloponneso videro epidemie superstiziose e crisi d’isterismo collettivo. Non fu certo il solo momento della storia umana in cui emersero nel tessuto di una società gli aspetti più aggressivi e terribili, ma in quest’epoca apparve per la prima volta chi seppe descriverli e valutarli con la luce dell’indagine razionale. Come scriveva Eric Dodds, «il nuovo razionalismo non insegnò agli uomini a vivere come bruti: questo l’hanno sempre saputo fare. Insegnò però a giustificare davanti a se stessi la loro brutalità». Ovvero, per usare le parole di Tucidide «è impossibile che la natura umana, quando si slancia con avidità verso un qualche progetto, trovi un freno nella forza delle leggi o in qualche altra minaccia».

Una tragedia come le Baccanti esprime anche in termini profondi una crisi delle istituzioni della vita associata: il clan gentilizio, la convivenza all’interno della città, i rapporti tra uomo e donna, le forme del potere. Tutto esce in frantumi dalla tragedia, che mette a nudo gli inquietanti spazi di rottura che si aprono non solo nella mente dei personaggi, ma anche nella società.
Impossibile per Tebe conservare l’equilibrio delle sue istituzioni davanti all’esplosione di tensioni che si genera nel cuore della città; altrettanto impossibile è la via di un completo abbandono fideistico al mondo proposto da Dioniso. Non si può vivere danzando sempre tra i monti, non si può tornare indietro verso la natura. Il mondo ordinato e stabile che Penteo cerca di tutelare è il risultato di un progresso che aveva condotto l’umanità dalla barbarie alla civiltà. Tuttavia, l’arrivo devastante di Dioniso e l’impotenza di Penteo mostrano che c’è qualcosa nell’uomo che è rimasto vittima della sua stessa opera civilizzatrice.
E’ difficile pensare che Euripide si riconoscesse nell’angusto e tradizionalista mondo d’idee di Penteo; è forse però ancora più difficile credere che si sentisse in consonanza con predicatori di culti nuovi e propugnasse il trionfo della religione sulla ragione. Dioniso non è comunque la salvezza, e neppure una ventata di novità che rinnova. Le Baccanti prospettano un culto in realtà antichissimo, precivile, sanguinoso. Forse la morale – se pur ne esiste una – delle Baccanti è questa: la salvezza non c’è da nessuna parte.
Così l’ultima tragedia del teatro attico, alla fine del V secolo, sembra concludersi con il riconoscimento di un dilemma irresolubile, e che l’ottimismo della ragione e la fede nel progresso -atteggiamenti entrambi fondamentali nell’età di Pericle – trovano un limite in quella parte oscura e sempre presente che l’uomo porta con sé.
Con Penteo, travestito, che esce di scena per avviarsi verso il Citerone dove incontrerà la sua fine, esce di scena anche, definitivamente, il modello di eroe proposto dalla tragedia: un individuo orgoglioso e nobile anche nel momento della sciagura.