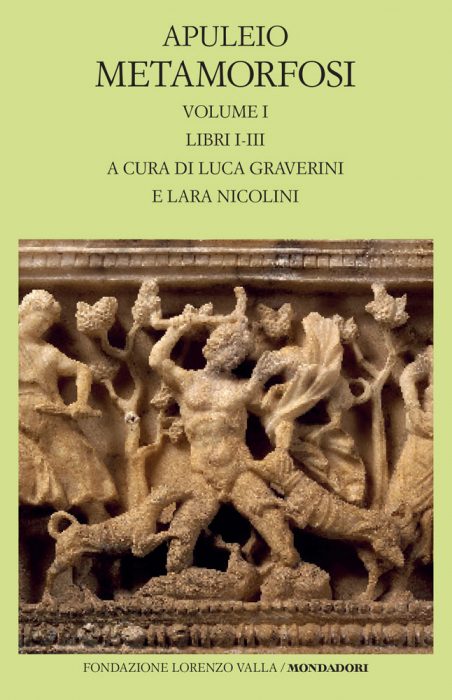“Lettore, ascoltami bene: ne sarai felice”. Tanto promette, sicuro si sé, il narratore delle Metamorfosi di Apuleio, un “racconto alla greca” che prende le mosse da un perduto Asino d’oro scritto appunto ingreco, ma si dipana poi con eccezionale inventività e audacia per seguire le vicissitudini di Lucio, trasformato in asino e miracolosamente restituito alla sua forma primigenia grazie all’intervento salvifico di Iside Regina.

Prigioniero del suo aspetto animale, Lucio conserva però intelletto e sentimenti umani: teme e desidera, osserva, ascolta, commenta. Domina in lui, come uomo, come asino e come narratore, una curiosità insaziabile, che trasmette al lettore-complice delle sue avventure. Proprio alla curiosità si devono le sue disgrazie. Osserva da una fessura la maga Panfile, che grazie a un unguento si trasforma in gufo, e smania di fare altrettanto, con esiti meno nobili e più duraturi. Lucio ripercorre così le tragiche vicende di Atteone, che aveva spiato Diana al bagno, e, trasformato in cervo, era stato sbranato dai suoi cani. Questa volta, per sua fortuna, la punizione è meno atroce, il ritorno tra gli uomini solo ritardato da una ricca serie di peripezie.
Nelle Metamorfosi tutto è magia. Il romanzo si apre con l’arrivo di Lucio in Tessaglia, una regione della Grecia da sempre associata al fascino e al rischio delle pratiche magiche, in cui -riflette- sassi, uccelli, alberi, acque, potrebbero essere null’altro che uomini trasformati dai poteri magici: “addirittura mi immaginavo che le statue e i ritratti avrebbero preso a camminare e le pareti a parlare, che buoi e altri animali avrebbero pronunciato profezie, e che dalla volta del cielo e dal disco del sole sarebbe disceso un oracolo”. Nelle Metamorfosi di Ovidio, un modello naturale per Apuleio, la trasformazione in animali, piante o rocce è sempre un episodio circoscritto che riguarda singoli esseri umani. Qui, invece, la metamorfosi, narrata o immaginata, è una dimensione pervasiva, una forma di realismo magico precoce e perturbante. In questo mondo in cui nulla è davvero quello che sembra, Lucio è convinto che tutto ciò che vedeva in quella città “fosse qualcos’altro, che tutto avesse assunto un altro aspetto a causa di qualche formula malefica”, e ci trascina con lui verso l’incerto confine tra allucinazione e sogno, dove saremo “saziati di storie incredibili”. Anche la svolta finale, che vede Lucio convertirsi ai riti di Iside in gratitudine perpetua per la grazia ricevuta, resta avvolta in questo clima di incertezza e di mistero: dobbiamo prendere la conversione alla lettera? O forse lo scarto rispetto al corpo del romanzo è tale da indurci a sospettare che la cifra dominante di questo esito inatteso sia l’ironia?
Una parte notevole del fascino di questo libro davvero straordinario deriva, per un lettore moderno, dal piacere con cui può individuarlo come sorgente di ispirazione per molti capolavori che verranno. Se l’arco principale della trama è quello tipico di un romanzo di formazione, che vede il giovane Lucio transitare dalle tresche giovanili con la bella Fotide alla rarefatta atmosfera del culto isiaco, dai colori torridi della Tessaglia al bianco luminoso del sacerdozio, le molte storie incastonate in questa struttura portante ricordano il Boccaccio del Decamerone: mogli infedeli, mariti sciocchi, amanti ingegnosi. Con Cervantes, invece, Apuleio condivide la scelta geniale di far muovere il suo protagonista sulle tracce del mito, e cioè di libri già letti. Lucio accosta ogni gesto, anche (anzi soprattutto) il più rozzo o banale, ai nomi illustri dell’immaginario greco-romano: Medea, Ganimede, Ecale e Teseo, Ifigenia, Pasifae, sono chiamati in causa di volta in volta per illustrare le sue disgrazie di asino, ma soprattutto per corroborare la dimensione costantemente autoriflessiva di un romanzo il cui eroe, nascosto nelle sembianze di asino, dice di aver conquistato saggezza ed esperienza pari addirittura a quella dell’Odisseo di Omero.
Non stupisce che anche l’autoriflessività sia oggetto di ironia: quando Lucio racconta la fiaba di Amore e Psiche, si dispiace, paradossalmente, di non averla potuta trascrivere, sfidando così la realtà della nostra esperienza di lettori; Apollo, dio greco, viene fatto parlare in latino “per fare un favore all’autore di questo romanzo”: nulla, si diceva, è davvero come sembra.

Inizia con questo volume la pubblicazione delle Metamorfosi per la collana della Fondazione Valla. Per la prima volta viene offerta al pubblico italiano l’opportunità di accostarsi al romanzo facendo tesoro della gran mole di contributi critici che ha caratterizzato gli ultimi decenni di studi su Apuleio, e che ha portato a comprendere sempre meglio la portata delle sue innovazioni. L’introduzione e il commento di Luca Graverini, che a questa stagione di rinnovato interesse ha dato un contributo importante in prima persona, sono in questo senso preziosi.
Non lo è di meno il nuovo testo critico procurato da Lara Nicolini, ricco di novità sia su singoli punti, sia nell’impostazione generale. A Graverini si deve anche la traduzione, limpida ed efficace. Tradurre Apuleio, va detto, è impresa che sfiora l’impossibile, perché ogni frase, ogni parola, sforza il latino ai limiti della comprensione, conia neologismi, recupera arcaismi, stravolge significati. Impone insomma al linguaggio la stessa violenza metamorfica che travolge Lucio, lo sospinge verso nuove avventure e frontiere insospettate. E’ un latino rutilante, versatile, ora solenne ora sboccato, elegiaco e tragico, colloquiale e dotto. Può darsi che almeno in parte questa fortissima carica di sperimentazione linguistica sia dovuta al fatto che Apuleio proviene dai margini dell’impero – era nato a Madaura, oggi in Algeria, intorno al 125 d.C. Poco importa, perché Apuleio mantiene in ogni caso, nell’originale o in traduzione, la sua promessa iniziale: “lettore, ascoltami bene: ne sarai felice”.