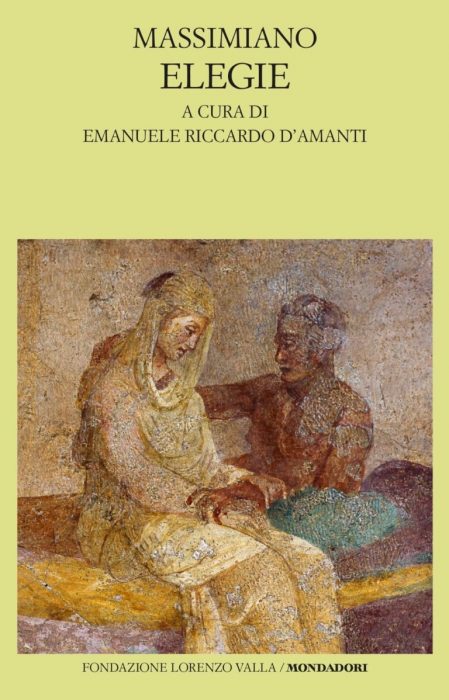Claudia Gualdana, Il Giornale
Non è una prova da poco essere poeta di talento e raffinata erudizione e vivere sul confine ultimo del mondo classico, con ostrogoti che scorrazzano su e giù per la penisola dettando legge e fondando regni. Massimiano poi era di famiglia aristocratica originaria della Tuscia, conosceva il greco, la tradizione giuridica romana, nonché i versi dei grandi che lo avevano preceduto. Probabilmente, non aveva una gran voglia di ridere di fronte allo spettacolo dell’ultimo scorcio della decadenza romana.
Non si creda tuttavia che facesse del romitaggio selvatico od epicureo. Rivestì ruoli pubblici, fu ambasciatore, amico di filosofi, visse insomma al centro del suo tempo, nonostante non fosse dei migliori. Era nato intorno al 490 dopo Cristo, lo si dice cristiano, forse, o forse no. In fondo, poco importa. A importare invece è quest’ultimo tesoro pubblicato dalla Fondazione Valla, le Elegie di Massimiano appunto, nella pregevole traduzione di Emanuele Riccardo D’Amanti (Fondazione Valla-Mondadori, pagg. 414, euro 50), in cui di teologia c’è niente. Ci sono invece l’amore, la detestata vecchiaia, il distacco dai sentimenti, dalla vita stessa infine, e la summa della tradizione elegiaca romana. Non proprio in quest’ordine: in poesia temi e suggestioni si accavallano e ci vuole una mano gentile ma ferma per sciogliere i fili e portarci oltre il verso a scoprirne l’origine e la destinazione. Sta di fatto che il Nostro è l’ultimo grande elegiaco romano. Ossia, nel suo poetare troviamo gli echi ellenistici di Callimaco, i tormenti dei poeti nuovi, l’olimpica grandezza dei cantori augustei, soprattutto Publio Ovidio Nasone. Un po’ come se avesse raccolto tutto quel che c’era di buono alle sue spalle per passare il testimone al medioevo, che infatti lo ha molto apprezzato, per quella curiosa translatio dei poeti erotici nella mistica cristiana che fa anche un po’ sorridere. Senza divagare troppo, meglio concentrarsi sulle Elegie e dire innanzitutto che, a detta del curatore, c’è in lui molto di Ovidio. Ma dell’Ovidio cupo dell’esilio a Tomi, lontano dalla Roma tanto amata e dalla sua rutilante vita mondana, e quindi scrisse i Tristia e le Epistole dal Ponto, piene di nostalgia per la felicità perduta e di riflessioni amare sulla condizione umana. Autobiografia pura quindi, con tutto quel che ne consegue. Il patrizio di rango senatorio alle prese con signore più o meno disinibite, per un affresco coloratissimo sulla libertà di costume, soprattutto delle donne, nel mondo antico. Sono solo sei le elegie, eppure c’è dentro tutta la civiltà classica nel suo lato più intimo: una panoplia sentimentale che è un saggio sugli usi e costumi degli antichi.
Nella seconda elegia, di notevole modernità, Massimiano ribalta lo schema secondo il quale la donna invecchiando perde attrattiva, l’uomo invece acquista fascino. Infatti non la pensava così Licoride, sua ex amante, che lo deride rivedendolo e lo chiama «vecchio decrepito». Lei invece, nonostante gli anni, «conserva i segni della beltà di un tempo» e si concede amanti giovani. C’è insomma anche un lato comico, o meglio latinamente satirico, dietro una malinconia a volte di maniera. Dopo aver pianto su se stesso, Massimiano cambia registro e con la maestria che riconosciamo solo ai grandi passa velocemente al riso.
Lo troviamo infatti a Costantinopoli per un’ambasciata, perdersi nelle grazie di un’etera smaliziata e bugiarda, senza poi concludere nulla. Forse per l’età che gli impedisce grandi slanci erotici, più probabilmente per la scarsa attrattiva di un’anima tanto meschina, sebbene racchiusa in un corpo grazioso e giovane. È un’elegia cruda, sprezzantemente erotica, anche un po’ volgare, in cui l’autore palesa tutta la sua disillusione di fronte alla pochezza del sesso. Insomma, l’amore o la sua parodia meritano un sorriso, una lacrima, poco altro. Infatti Massimiano non si è mai sposato: non credeva nell’amore. Non c’è una Lesbia a tirare le fila del suo discorso, c’è invece la vecchiaia, sua unica croce, peraltro senza delizia. C’è invece tanto distacco da filosofo nelle sue parole, sempre misurate al millimetro: mai una sbavatura, un eccesso, una virgola di troppo. Il testo a fronte, per chi mastica un po’ di latino, sta lì a dimostrarlo. Il resto lo fa l’ottima traduzione, in cui c’è anche il vezzo di usare il termine «nughe», tanto per ricordare Catullo, di cui Massimiano è uno scettico (o forse stoico?) rovesciamento, in cui le bagatelle (questo il significato di «nughe«) invece di portare alla tragedia sentimentale sotto sotto fanno ridere.

Si diceva di filosofia e non a caso, perché nella terza elegia c’è un personaggio ingombrante, Severino Boezio, amico del Nostro, nella curiosa veste di paraninfo e consigliere. Se c’è del cristianesimo nelle Elegie, lo troviamo qui, nelle sagge parole del grande logico e matematico cui tanto deve chi è venuto dopo di lui, nei cosiddetti secoli bui. È un’elegia del ricordo: Massimiano rimpiange Aquilina, suo primo, impossibile amore. I genitori separano i due giovani, l’autore chiede aiuto al saggio Boezio, più anziano, il quale gli spiega che l’unico modo per guarire dalla malattia d’amore è abbandonarvisi. Il poeta invece preferisce allontanarsi per proteggere la ragazza, sé stesso e la sua stoica continenza. Non si abbandonava facilmente agli slanci, e Boezio, se gli suggerisce di farlo, è solo per guarire da «tal peste».
Insomma, l’amore è una pena, la vecchiaia l’opposto dell’encomiabile età della saggezza cara a Cicerone: «libera, ti prego, la mia vita infelice da una simile prigione: ormai per me la morte è riposo». C’è la fine di un mondo, nelle Elegie di Massimiano, pur con tutti i suoi crismi e un retaggio profondo come un abisso nel tempo. Egli non temeva la morte, né l’amore, ma ciò che è brutto, deforme, triviale, nell’animo e nel corpo. In questo è assolutamente pagano e come tale universale ed eterno. Le sue parole si attagliano a ogni momento, soprattutto per chi ha visto già un bel po’ d’acqua passare sotto i ponti.