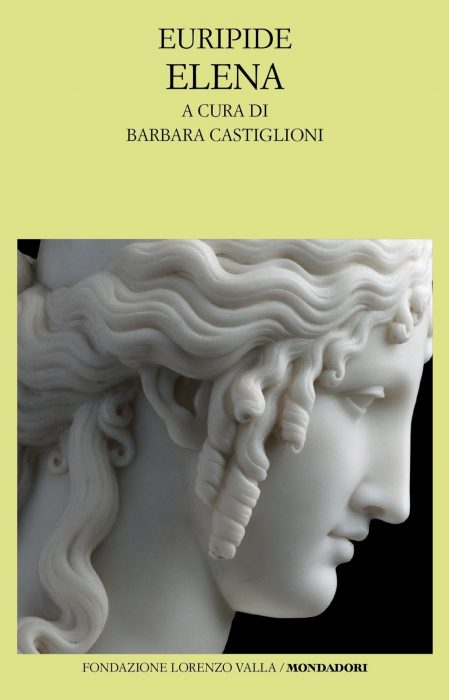Marco Beck, L’Osservatore Romano
Nella sua Storia della Bellezza (Bompiani, 2004) Umberto Eco, grande studioso di estetica, oltre che semiologo, saggista eclettico e narratore di fama mondiale, osservava: «La Bellezza non è mai stata qualcosa di assoluto e immutabile, ma ha assunto volti diversi a seconda del periodo storico e del paese: e questo non solo per quanto riguarda la Bellezza fisica (dell’uomo, della donna, del paesaggio) ma anche per quanto riguarda la Bellezza di Dio, o dei santi, o delle idee…». Né potrebbe essere altrimenti, poiché «sono stati gli artisti, i poeti, i romanzieri a raccontarci attraverso i secoli che cosa essi considerano bello, e a lasciarcene degli esempi». Un esempio eclatante, un’icona dell’eros, un paradigma ineguagliabile di bellezza femminile che ha attraversato i secoli assumendo via via, nella rappresentazione di artisti e scrittori, volti sempre diversi, spesso contrastanti e sconcertanti, è la figura di Elena di Sparta, incarnazione suprema di una femminilità universale e transtemporale per designare la quale Goethe coniò la definizione di «eterno femminino», das Ewig-Weibliche.
Sono innumerevoli i ritratti che la Weltliteratur ha dedicato alla figlia di Tindaro (o piuttosto di Zeus, unitosi a Leda in forma di cigno), elevata dal mito al rango di “donna più bella del mondo”, andata sposa a Menelao, principe di Micene e fratello di Agamennone, sedotta e rapita da Paride figlio di Priamo, condotta a Troia dall’amante e infine, al termine del conflitto decennale fra i Troiani e gli Achei decisi a riappropriarsene, restituita dal marito (con la forza? con il suo consenso? dopo quali peripezie?) a Sparta, al suo ruolo di sposa fedele e madre amorosa. Si prova quasi un senso di vertigine nel lasciarsi guidare dalla grecista Barbara Castiglioni, curatrice di una pregevole edizione dell’Elena di Euripide (Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori, 2021, pagine cx-386, euro 50), alla visita, attraverso una dotta Introduzione, di una “galleria” letteraria popolata dai mille iridescenti profili di un’unica donna effigiata ora come una creatura dal fascino soave, ora come una sensuale incantatrice di uomini, ora come un’adultera pentita, ora come un’egocentrica tessitrice di inganni. Il nocciolo della questione, posto in termini teoricamente giudiziari, si riduce a un’alternativa secca: colpevole o innocente? Ma neppure è escluso il paradosso di una terza soluzione, impregnata d’inestricabile ambiguità: colpevole e, nel contempo, innocente. «La sua dote involontaria, la bellezza, desta spavento e meraviglia, determina il suo destino e la rende, contemporaneamente, vittima e carnefice», secondo l’efficace sintesi di Barbara Castiglioni.
Ambigua appare, fin dall’origine epica della vicenda di Elena, la raffigurazione che ci propone il terzo canto dell’Iliade, dove il riconoscimento di una venustà pari a quella delle dee immortali si accompagna, nell’ottica dei vecchi troiani, al desiderio che la donna per la quale si sfidano due civiltà «torni per nave alla sua casa», ponendo fine alla strage. Mentre, per converso, lo stesso re Priamo indulge a discolparla e ad accoglierla con paterna tenerezza. E l’elemento dell’ambivalenza riaffiora anche nell’Odissea (canto IV), che mescola la premurosa ospitalità della regina di Sparta nei confronti di Telemaco con la rievocazione di un’inquietante episodio risalente all’ultima notte da lei vissuta a Troia.
In un’alternanza di condanne e assoluzioni la tradizione del “processo a Elena” percorre tutta l’antichità greco-romana, dividendo i poeti nei due opposti schieramenti dei “colpevolisti” (Eschilo nell’Agamennone, come Virgilio nel II e nel VI libro dell’Eneide) e degli “innocentisti” (il lirico Stesicoro, Seneca tragico sia pure con riserve, l’Ovidio delle Metamorfosi evocatore di un’Elena invecchiata e piangente). Implacabile, nel Medioevo, la censura provocata anche dal parallelismo con Eva, che induce Dante a relegare la perversa seduttrice nel cerchio dei lussuriosi: «Elena vedi, per cui tanto reo / tempo si volse» (Inferno V 64-5). Frivola creatura nel Troilo e Cressida di Shakespeare, subdola calcolatrice nel Don Quixote di Cervantes, nel Faust di Goethe Elena assume una valenza poliedrica e rivela un amaro turbamento che si riconnette allo scavo psicologico del dramma di Euripide. La deprecata impossibilità di coniugare bellezza e felicità riecheggia infatti il lamento del personaggio euripideo, ai vv. 304-5: «Per le altre donne la bellezza è una fortuna, / mentre per me è stata proprio una rovina». Flussi e riflussi proseguono in età moderna e contemporanea. La moglie di Menelao e amante di Paride accende la fantasia ri-creatrice soprattutto dei poeti, da Pascoli a Mandel’štam, da Yeats a Hofmannsthal, da Seferis fino a Walcott.
Portando sulla skenè del teatro di Dioniso la sua Elena, nel 412 a.C., Euripide, inesauribile sperimentatore e indagatore della psiche femminile, dovette in qualche modo spiazzare il pubblico ateniese. In drammi precedenti (Andromaca, Ecuba, Elettra, e in seguito anche nelle due Ifigenie) aveva espresso un atteggiamento marcatamente negativo verso la “responsabile” della guerra acheo-troiana. Ed ecco che ora, d’emblée, la sua nuova interpretazione della Tindaride mostra una rotazione di 180 gradi. Elena non è più, o perlomeno non vuole più essere, un mero oggetto del desiderio maschile. È ancora affascinante, certo, ma anche virtuosa, ricca di buoni sentimenti: tenacemente innamorata dello sposo legittimo, nostalgicamente ancorata al ricordo della figlia Ermione. È diventata insomma un modello di kalokagathía, un connubio di avvenenza e moralità, espressione drammaturgica di una femminilità nutrita di sensibilità, avvedutezza, intelligenza.
La plausibilità di questo rovesciamento di prospettiva poggia su un filone mitico alternativo, la cui fonte è rinvenibile in un frammento del già citato Stesicoro. Secondo tale versione, peraltro minoritaria, Elena non sarebbe mai andata a Troia. Ad accompagnare Paride sarebbe stato un eidolon, un simulacro, un fantasma con le sue identiche fattezze, “fabbricato” da Era per vendicarsi di Afrodite vincitrice della famosa contesa fra le tre dee sul monte Ida. La vera Elena sarebbe invece stata trasportata segretamente in Egitto da Ermes, e lì affidata alla protezione del monarca locale, Proteo. Assoluta innocenza, dunque, della presunta femme fatale. Valutando una così immaginosa “riabilitazione” in base alle categorie della letteratura odierna, quello di Euripide sembrerebbe quasi un esercizio ante litteram di narrativa fantasy.
A somiglianza dell’Alcesti e dello Ione, la trama di questa “tragicommedia” procede senza grossi sussulti drammatici verso un lieto fine degno di un romanzo d’avventura. Elena si difende strenuamente dalle avances di Teoclimeno, succeduto al padre Proteo e intenzionato a sposarla. Sulla costa egiziana sbarca in seguito a un naufragio Menelao, il quale stenta dapprima a credere alla spiegazione fornitagli dall’autentica Elena circa la presenza a Troia di un’Elena fasulla. Avvenuto poi un appassionato riconoscimento all’insaputa del sovrano, i due sposi ritrovati concertano un piano per tornare in patria con la benevola complicità della profetessa Teonoe, sorella di Teoclimeno. Fingendo di aver avuto notizia della morte per annegamento di Menelao, Elena ottiene dal suo corteggiatore la disponibilità di una nave su cui compiere in alto mare un fittizio rito funebre in memoria del defunto. Teoclimeno cade nella rete. E la tragedia (tale solo per convenzione) si conclude dunque con una fuga marittima che, per ironia della sorte, risulta simile al rapimento della stessa Elena da parte del fedifrago Paride, ma che trae legittimazione dal ricostituito vincolo coniugale dei due protagonisti e dall’intervento di Castore, il Dioscuro fratello di Elena, apparso sulla scena come risolutivo deus ex machina.
È evidente che ci troviamo di fronte a una svolta cruciale nella storia del teatro ellenico. Ormai, dietro l’angolo tra il V e il IV secolo a.C., si comincia a intravedere il realismo sentimentale della commedia “borghese” di Menandro.