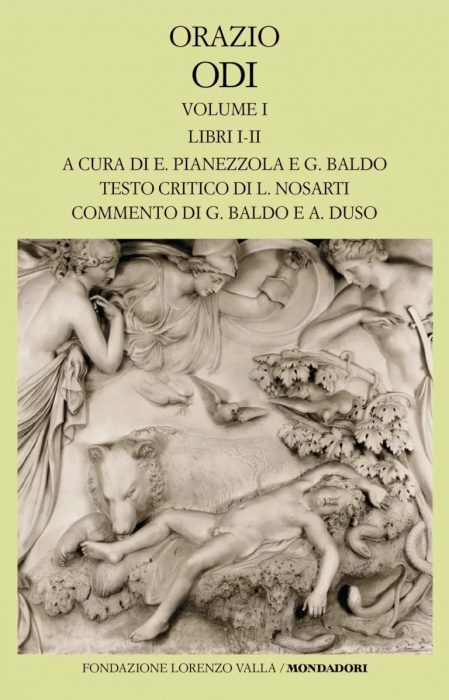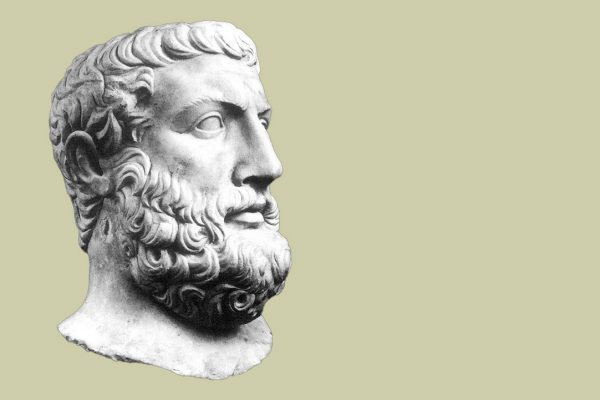Marco Beck, L’Osservatore Romano
«Exegi monumentum aere perennius / regalique situ pyramidum altius…». Così risuona ancora oggi, e per sempre risuonerà, l’auto-vaticinio formulato da Quinto Orazio Flacco (Venosa, 65 a.C. – Roma, 8 a.C.) in apertura della trentesima e ultima tra le Odi del Libro III: «Monumento più durevole del bronzo, più svettante / delle squallide piramidi regali, è quello che ho innalzato…». Con perentoria, inaudita chiaroveggenza il poeta venosino presagì il destino di fama immortale che avrebbe premiato la sua opera lungo venti secoli di posterità. Scommessa vincente, come si desume anche dall’autorevole testimonianza di Dante, benché il sommo vate ignorasse o sottovalutasse proprio i Carmina, le Odi figlie dell’ispirazione lirica del “collega” latino. A venire incontro al pellegrino e a Virgilio nel Limbo è infatti, con altri tre «spiriti magni» – Omero, Ovidio e Lucano –, «Orazio satiro» (Inferno IV 89), considerato dunque solo come autore delle Satire e delle Epistole.
Nacque forse da uno scatto di smodata presunzione, di orgoglio smisurato, quella profezia su un proprio futuro letterario senza tramonto? E quella sorta di apoteosi non contraddice il saggio precetto dell’equilibrio, della moderazione, dell’aurea mediocritas? Non sconfessa la filosofia del carpe diem? Sospetti infondati. Una conoscenza approfondita della psicologia di Orazio, quale emerge da un corpus poetico ricco di elementi autobiografici, sia pure velati dal filtro di una mescolanza tra realtà e finzione, conduce in un’altra direzione: quella di una preveggenza sorretta sia da una serena consapevolezza del proprio talento, sia dall’encomio dei lettori coevi, a partire dallo stesso Augusto e dall’élite del circolo di Mecenate. Né va trascurato un certo grado di autoironia tendente a smussare le punte di discutibile enfasi nell’autocelebrazione di un uomo che – stando al lessico dantesco – riteneva di potere, per virtù di genio poetico, “etternarsi”. Lievemente autoironica appare anche la fantasiosa metamorfosi del poeta in nobile cigno nell’incipit di un’altra ode “di commiato” (II 20): «Non usitata nec tenui ferar / penna biformis per liquidum aethera / vates… non ego… obibo», ovvero, nella versione di Emilio Pianezzola, «Non un’ala comune, non un’esile ala mi porterà / attraverso l’aria limpida nella duplice forma di poeta /… io non… morirò».
La personalità di Pianezzola (1935-2016), a lungo ordinario di letteratura latina all’Università di Padova, ha impresso un’orma profonda nella nuova edizione parziale delle Odi pubblicata nel novembre del 2024 da Mondadori in sinergia con la Fondazione Lorenzo Valla: Volume I, Libri I-II (cui seguiranno in futuro i Libri III-IV), pagine ccii-510, euro 50. A lui si devono la progettazione, la stesura dell’Introduzione generale e la traduzione modellata sul testo critico a cura di Lorenzo Nosarti, nonché l’impostazione del dovizioso commento che una coppia di latinisti suoi eredi nello stesso ateneo patavino, Gianluigi Baldo e Antonella Duso, ha elaborato con una funzionale stratificazione di livelli: prima di essere analizzata mediante una fittissima griglia di lemmi, ogni singola ode passa attraverso il vaglio di successive “rubriche”: introduzione, datazione, destinatario, motivi e modelli, struttura, metrica.
Un Orazio redivivo si compiacerebbe di questo aggiornato inveramento della sua rivendicazione d’immortalità culturale. Al tempo stesso, si stupirebbe nel constatare quale moltitudine di edizioni, studi, traduzioni, interpretazioni sia proliferata, nella innumerabilis annorum series, intorno al suo imperituro monumentum: sono più di un centinaio le pagine in cui si dipana l’elenco delle abbreviazioni bibliografiche ricorrenti nel volume mondadoriano. Su questo catalogo destinato agli studiosi il lettore mediamente colto potrà comunque sorvolare per un accesso diretto alla sezione centrale, dove la traduzione – di pregevole qualità, appena mancante, a mio forse opinabile avviso, di un’ultima levigatura – si specchia nell’inarrivabile perfezione del testo oraziano a fronte.
Un esperto classicista oltre che saggista e narratore, Giuseppe Pontiggia, consigliava di tuffarsi nel contatto con i testi greci e latini senza il fardello di un “filologismo” esasperato, ma anche prescindendo da mediazioni banalmente divulgative. Prima di tutto bisogna gustare la bellezza, il fascino, il sapore dell’originale sulla scorta di alcune essenziali linee-guida. Solo in un secondo momento converrà ricercare i desiderati chiarimenti e approfondimenti (indispensabili per orientarsi di fronte all’iridescente complessità e alla balenante pregnanza del linguaggio di Orazio) con il ricorso a un’ermeneutica e a un’esegesi di spessore specialistico ma immuni dagli eccessi di un’accanita “speleologia” critica.
L’edizione avviata da Pianezzola e sviluppata dai membri della sua équipe mette in pratica questo intelligente paradigma di lettura. Scritta con la limpidezza di un cattedratico che rifugge dalla prosa aulica dell’accademia, l’Introduzione funge da ouverture in cui si annunciano temi e stilemi caratteristici della “romanizzazione” marcatamente innovativa – da un lato intimistica, dall’altro al servizio dell’ideologia augustea – operata da Orazio, con straordinaria perizia metrica, sul palinsesto della grande lirica greca: tanto da poterlo considerare «un poeta greco in lingua latina». Come supremo modello di questa grecità latinizzata si staglia, sopravanzando la pur ammirata sensibilità femminile di Saffo, il più congeniale Alceo: tipicamente alcaica è l’alternanza fra impegno civile, felicità del canto simposiaco, abbandono all’effusione erotica. Di tali e molti altri “ipotesti” esiste, palese o segreta, una rete che Baldo e Duso hanno con pari acribia ricostruito.
Liberi dall’emulazione degli archetipi eolici, ma proprio per questo umanamente più vissuti, più veri, risultano i carmina di carattere esistenziale e sapienziale, influenzati semmai dalla poesia (in primis Callimaco) e dalla filosofia (scuola epicurea di Ercolano, diatriba stoico-cinica) della civiltà ellenistica-alessandrina. Si sgranano così, screziate dal gioco delle callidae iuncturae, riflessioni insieme lucide e visionarie sull’ineluttabilità della morte in contrasto con l’eterna ciclicità delle stagioni, sulla vanità di un insaziabile accumulo di ricchezze, sul valore dell’amicizia, sul rapporto con gli dèi e con i potenti, sul godimento di un angulus appartato in grembo alla natura come antidoto al “male di vivere”. E fioriscono luminose icone di giovani donne ritratte nella loro acerba purezza o nella loro matura sensualità. La più seducente? Làlage, l’amabile fanciulla cantata nell’ode I 22: «lei che sorride dolcemente / e dolcemente parla».