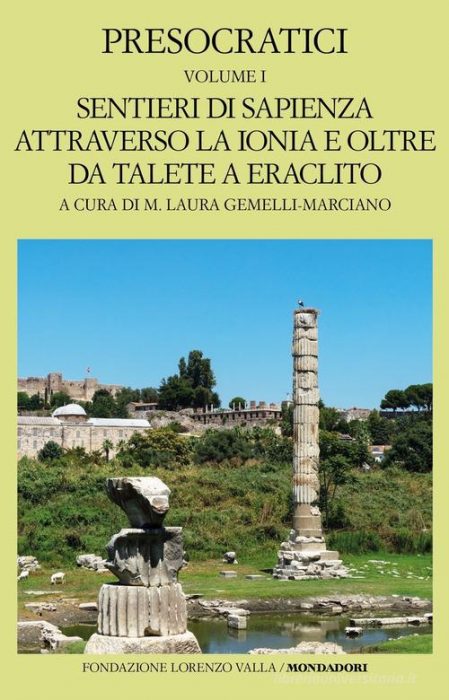Barbara Castiglioni, Il Giornale
Tra seconda metà del VII e la prima metà del VI secolo a.C., emergono, in Grecia, in aree esposte a contatti con popoli del Vicino Oriente o coi territori della Scizia, «uomini divini e purificatori»: come Aristea di Proconneso, che cade morto in una bottega, viene rapito da Apollo e arriva nella terra degli Issedoni; è informato dell’esistenza degli Iperborei e degli Arimaspi, che hanno un occhio solo e lottano per sottrarre l’oro ai grifi che lo custodiscono; poi sparisce di nuovo, e ricompare duecentoquarant’anni più tardi a Metaponto, sotto forma di corvo, e, infine, nelle vesti di un fantasma che racconta la sua strabiliante vicenda. O Ermotimo di Clazomene, secondo Eraclide la terza reincarnazione di Pitagora, che giace nudo per entrare in catalessi e lasciare che il nous – l’anima – esca dal corpo e vaghi per il mondo per riportare messaggi o profezie. O Epimenide di Creta, che dorme in una caverna per cinquantasette anni, e si risveglia con poteri mantici e di purificatore: Epimenide si nutre solo di un cibo magico, lo halymon, che conserva in uno zoccolo di bue, non emette escrementi ed è onorato come un eroe. Questi personaggi, fondamentali per chiarire molti aspetti legati ai cosiddetti «presocratici», hanno poco – anzi, nulla – a che fare con la filosofia speculativa di matrice platonica o aristotelica, in cui, a partire dall’antichità, gli stessi presocratici sono stati ostinatamente ingabbiati, come osserva Laura Gemelli-Marciano nella sua densa, preziosa introduzione al primo volume della nuova edizione dei Presocratici: da Talete ad Eraclito (Fondazione Valla, € 50), in cui si distacca profondamente dall’edizione “canonica” di Diels e Kranz, riuscendo in un’impresa quasi titanica: la liberazione – e la rivelazione – dei “veri” presocratici. Che sono molto di più di quel sistema di pensiero che non sono mai stati, e si nascondono dietro molti capisaldi del nostro immaginario: ad esempio, l’idea dell’eterno ritorno. Nietzsche l’aveva conosciuta in un frammento di Eudemo, che la attribuiva ai pitagorici, e l’aveva trovata assurda; fino all’istante fatale, in cui, nel 1881, a Silvaplana, aveva avuto la sua rivelazione («io sono la tua affermazione in eterno: perché io ti amo, eternità!»). Ma anche l’eterno ritorno, attraverso cui voleva illudersi di avere eliminato Dio, non è che un mito, o solo «uno dei grandi simboli attraverso cui Dio si rivela», come scriveva Carlo Diano. E i presocratici hanno a che fare con il mythos, nel senso greco del termine, non meno di quanto abbiano a che fare con l’idea di Dio e con il logos, e sono legati anche ad una sfera esoterica, tra magia e filosofia della natura: Empedocle, ad esempio, si definiva un mantis, un guaritore, un «dio immortale e non più mortale»; Parmenide insegnava una Verità che gli era stata comunicata nell’aldilà dalla signora dell’oltretomba, Persefone; Anassagora si sarebbe presentato ai giochi olimpici vestito con un mantello, perché aveva previsto un acquazzone; Pitagora, “uomo divino” che si considerava una reincarnazione di Apollo Iperboreo, poteva compiere viaggi estatici, conosceva ogni cosa e proclamava la dottrina della trasmigrazione dell’anima: quasi uno “sciamano”, che sottoponeva i suoi allievi a prove durissime e per cui «i piaceri sono un male, perché siamo venuti al mondo per punizione e dobbiamo essere puniti». O forse, solo il «capostipite degli impostori», come lo accusava Eraclito: esortava a pregare scalzi, a non tagliarsi le unghie durante i sacrifici, a lavare il piede sinistro prima del destro, a sputare sui propri peli rasati, a non attraversare un luogo in cui si era accosciato un asino e ad astenersi dalle fave, che sarebbero simili ai genitali. Eraclito di Efeso, forse la figura più affascinante, invece, polemizzava vigorosamente («minacciava punizioni dopo la morte, profetizzava il fuoco») contro le iniziazioni private, le purificazioni con il sangue e l’ignoranza di chi praticava riti in maniera inconsapevole: non rifiutava la religione tradizionale, ma neppure alcuni aspetti delle culture mesopotamica, persiana ed egizia, e tentava di rievocare il significato profondo di dèi e riti che gli uomini – anche e soprattutto gli «innovatori» contro cui scagliava il suo infinito disprezzo – ignoravano. Da qui deriva la sua profonda solitudine, testimoniata da periodi di isolamento nella natura selvaggia, come Mosè ed Elia, e un ancor più profondo dissidio coi propri simili, che non poteva contrastare, perché – diceva – «il carattere è il destino dell’uomo». Come una Sibilla che «con bocca delirante grida parole cupe, disadorne e prive di fragranza», Eraclito, per cui il logos era universale ed eterno, esortava ad attendere l’inatteso: «chi non lo attende non lo troverà, perché non lo si può ricercare e non ha vie di accesso». Un monito – o un desiderio – non troppo diverso, in fin dei conti, dalla meravigliosa esortazione del profeta Isaia: «sii la vedetta notturna: quello che vedi grida».